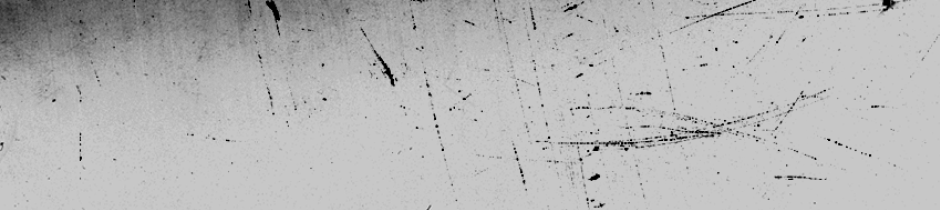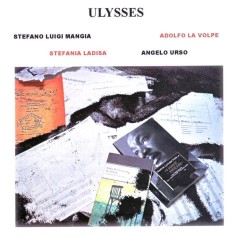ULYSSES
Stefano Luigi Mangia (voice, alto sax, toys)
Stefania Ladisa (violin, toys, voice)
Adolfo La Volpe (acoustic and electric guitars, harmonium, electronics, banjo, cetera corsa, voice)
Angelo Urso (double bass, toys, voice)
Tracklist: PLAY
1-Impro#1 2:30
2-Stratosfonie [to Demetrio Stratos] (music S.L. Mangia / lyrics John Cage) 8:55
3-Impro#2 3:01
4-Impro#3 2:45
5-Aforisma-LDV [to Leonardo da Vinci] (music S.L. Mangia / lyrics Leonardo da Vinci) 0:59
6-Composizione in 48 cm [to Fedor Dostoevskij] (music Stefania Ladisa) 6:06
7-1969 [ to A. Einstein] (music Angelo Urso) 1:14
8-Mlk [to Martin Luther King] (music S.L. Mangia) 3:30
9-Cada Jardyn Solo [to J.L. Borges] (music Adolfo La Volpe / lyrics J.L.Borges) 5:31
10-Impro#4 3:42
11-Perfetta Letizia [to San Francesco] (music Stefania Ladisa) 1:45
12-La virtù temporale [to Kurt Gödel] (music Adolfo La Volpe) 1:13
13-Ulysses [to Ulysses] (music and lyrics S.L. Mangia) 6:24
Total Time: 47:37
Recorded and mixed by Adolfo La Volpe at Adhil Studio, Ceglie del Campo (Bari, Italy), February-April 2011; cover concept by Stefano L. Mangia and Valentina Serra; inner sleeve photo by Valentina Serra; produced by Ulysses and Leo Feigin.
Special thanks to: Alessandro Zignani, Valentina Serra, Valerio Daniele, Pierpaolo Martino.
Liner Notes:
LA FORMULA DI UN SOGNO
La musica si occupa di archetipi: rappresenta modelli universali radicati nel nostro inconscio. La musica è, dunque, una grammatica dell’immaginario collettivo: si nutre di miti. Un mito, è una vicenda che, se narrata, torna ogni volta ad essere sogno. Comporre musica, in questa alba del nuovo millennio, significa organizzare le proprie tracce mnestiche secondo sogni ricorrenti. Le ricorrenze interiori del tema di Ulisse, in questo concept album, diventano topografie della personalità; qualcosa di simile a quanto tentato da Joyce nell’Ulysses: la storia di un uomo che, sognando di essere qualcun altro, viaggia nell’immaginario di tutti coloro che incontra. Gli autori di questo Ulysses, allo stesso modo, fanno passare dentro la propria memoria associativa filamenti dei miti contemporanei, biografie sonore di viaggiatori per i quali vale la definizione di Machado: “no hay caminos, hay que caminar”.
La prima connotazione comune a tutti i simboli mitopoietici: gli “eroi”, dell’album, è il loro essere viaggiatori dell’impossibile, esploratori dei limiti. Questo vale per Kurt Gödel, il cui teorema dimostrò che la matematica è un’arte, non una scienza; per Martin Luther King, fautore di quella paradossale lotta contro le pulsioni umane che è la nonviolenza; e ancora, Leonardo da Vinci: il teorico del microcosmo-uomo (il “pentalpha”) nelle cui proporzioni si rispecchia l’Harmonia Mundi; Jorge Luis Borges, che ha strutturato l’inconscio come una biblioteca; San Francesco: santo, paradossalmente, per il suo panteismo pagano; Fëdor Dostoevskij: l’illuminato psicologo della santa epilessia; Albert Einstein, che rese la Fisica un discorso sull’errata percezione del mondo, distruggendo, di fatto, l’Umanesimo; infine, Demetrio Stratos, che mise la rigenerazione della musica al confine irraggiungibile tra suono e respiro. Ognuno di questi personaggi-simbolo viene evocato secondo differenti attitudini: pratiche della tradizione strumentale ripensate e rovesciate di segno; frammenti testuali che sono più echi della sua voce, che non “discorsi”; canoni tra stilemi diversi attinti al suo immaginario o, ancora, stranianti sentieri che si biforcano: tra musica e testo, segno e significato. L’idea sottesa è tracciare una mappa di quanto, dell’utopia universalistica irradiata lungo tutto il Novecento dall’archetipo del viaggio, è rimasto attivo nei nostri sogni. Ulysses, quindi, è un diagramma della crisi, ma anche una ricognizione dall’alto dei percorsi possibili; sempre, infatti, la libertà è un trauma.
L’elemento più interessante del progetto, è la natura geometrica delle Forme compositive. Viene in mente quel bizzarro romanzo su di un mondo bidimensionale che è Flatlandia di Abbot; allo stesso modo, in Ulysses troviamo brani composti di sequenze ricorsive millimetriche (continuum spaziotemporale) accanto ad altri che si replicano avvolgendosi su se stessi, come nastri di Möebius; strutture speculari rovesciate, dove la prospettiva è multifocale, alla maniera di Escher, insieme ad altre modulari, frammentarie, come le figure di un sogno che si ripete notte dopo notte, senza mai, per il risveglio precoce, potersi concludere. Si tratta, in sostanza, di una nuova concezione del “contrappunto”: qui, una maniera di far interagire esperienze eterogenee senza ridurle a codice. In mancanza di una grammatica del nuovo Umanesimo, comporre significa, ai tempi nostri, privilegiare il fenotipo sul genotipo: la testimonianza di uno scollamento tra la visione del mondo, che spiega, e la sensazione, che rinnova il mistero. Ulysses vale come mappa dell’epoca attuale, dunque: e la mappa, diceva Wittgenstein, non è il territorio. Nelle improvvisazioni che segnano i confini tra progetto e avventura, itinerario intellettuale e mistico excessus mentis, troviamo i profughi della Modernità cui si deve Ulysses: questo album-diaspora, mettono a confronto ciò che delle loro opere è rizoma e spora, sostanza alchemica di ogni possibile permutazione.
Simile esoterismo dell’immaginario rappresenta uno stilema assai raro nel panorama musicale contemporaneo. Alchimia, significa arte del minimo passaggio tra stati contigui della medesima materia; in musica, una sorta di purificazione quintessenziale di una vecchia prassi: la Variazione. Uno dei fermenti vivi dell’album, in effetti, è come le vecchie Forme riemergono in quanto tracciato di ricordi: memorie di viaggiatori favolosi dei quali si siano sentite narrare, all’alba della coscienza, storie di gesta. La poetica del frammento, l’arazzo della citazione: tutto ciò che il già evocato Borges riteneva l’unica evidenza strutturale possibile, nell’immaginario contemporaneo, diventa, qui, un paesaggio di rovine dove le orme dei testimoni sono più importanti dei pilastri che reggono le volte. Gli dèi, in noi, sono diventati sentimenti, stati d’animo; le Forme, si sono trasformate in mitologie oniriche.
Luigi Dallapiccola ha concepito il “testo” del suo Ulisse: feticcio segreto del concept album, come collage di frasi, battute, scampoli di vita reperiti sui muri delle stazioni che si trovava ad attraversare. Ulisse, era ciò che accendeva in lui la memoria associativa. Per vie diverse, anche questo Ulysses procede secondo la stessa poetica; solo, il tempo che è passato ha modificato la geosinclinale del paesaggio: ora, è una regressione allo stato amniotico, la purezza edenica di ogni larvale divenire. Un momento di albedo, di magma allo stato nascente, questo Ulysses: qualcosa di affine a quella macchina combinatoria che Mallarmé teorizzava, quando predisse che i nuovi poeti sarebbero stati guardiani del tempo, cartografi di esperienze remote, e non teorici di sterili algoritmi. Perché in musica sempre, ogni Orfeo che si volge indietro, cerca una nuova Euridice.
Alessandro Zignani.